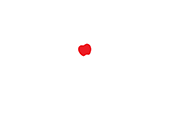Gomito a gomito sui banchi di scuola per scoprire, insieme alle persone, altre culture e altre religioni
Ci sono due momenti che ricordo molto distintamente, nella mia carriera scolastica.
Il primo in terza elementare. Ero l’unica bambina “straniera” di tutta la scuola. Straniera, poi, sarebbe un termine scorretto, ed anzi non ricordo di essere mai stata definita così. Ero nata in Italia, come tutti i miei compagni, e parlavo l’italiano esattamente come loro. C’era solo la mia pelle scura, ogni tanto, a ricordare loro che venivo da un paese lontano, pur non essendomi mai mossa in vita mia.
Bene, un giorno arrivò in classe una bambina stupenda, dagli occhi a mandorla e i capelli dritti e neri, lucidi. Silenziosa. Veniva dalla Thailandia, un paese che non sapevamo nemmeno dove fosse.
L’insegnante di italiano decise di farla sedere accanto a me, perché “ci saremmo capite”. Lei non parlava l’italiano, ma aveva un sorriso aperto, sincero. Diventammo presto amiche per la pelle, e lei imparò la lingua in pochissimi mesi. Negli anni successivi sempre fummo accomunate nel tormentone dell’insegnante: “Incredibile! Le uniche due straniere di questa classe sono le migliori in italiano!”
Il secondo fu al liceo classico, subito dopo l’11 settembre 2001. C’era chi proseguiva col programma come se nulla fosse accaduto, ma ci fu anche qualche professore che, di punto in bianco, iniziò a farmi domande in classe sull’Islam. Rispondevo, sorridevo, mi giustificavo. Ma il mio stupore, forse, è servito a mostrare ai miei compagni una banale verità: non potevo certo essere io, studentessa italoegiziana di religione musulmana, a spiegare loro perché fossero cadute le torri gemelle. Io, e la mia religione, non c’entravamo proprio un bel niente.
In generale, spesso sono stata “usata” come spunto per riflettere sull’intercultura, sul dialogo tra religioni. La cosa, anziché disturbarmi, mi ha sempre fatto sorridere. Ostacoli o incomprensioni all’incontro tra culture o civiltà (perché di incontro si tratta, e non certo di scontro, come alcune interpretazioni cercano ossessivamente di farci credere) sembrano
magicamente dissolversi quando all’astrazione si oppone il semplice, banale ma efficace guardarsi negli occhi. Se chi sembra diverso ti è accanto tutti i giorni, se conosci il suo volto e la sua voce, beh allora ogni rigidità mentale soccombe.
Ed anche la persona più ostile è indotta, quasi naturalmente, al confronto.
È per questo che non capisco chi propone, nella scuola specialmente, separazioni, distacchi.
Lo scambio arricchisce certamente chi viene da un altro paese, ma anche i ragazzi italiani ai quali si aprono prospettive e orizzonti più vasti.
Nel confronto con i nuovi arrivati, ma in particolare in quello con le così dette seconde generazioni, imbevute contemporaneamente di due diverse culture e, per forza di cose, con un occhio critico ben allenato. Dentro e fuori a mondi diversi, ne percepiscono pregi e difetti, hanno voglia di affermarsi, sono dinamici, cosmopoliti.
Ed è quindi bene che oltre ad andare al ristorante cinese ogni tanto, o a parlare di kebab o riso al curry, iniziassimo a chiederci davvero cosa siano, queste culture non occidentali; a chiedere ai bambini di parlare dei loro paesi, dei giochi, delle tradizioni a loro care. Non come gesto di cordialità e attenzione, ma per arricchire i nostri bambini, i nostri studenti, e le menti di noi tutti.